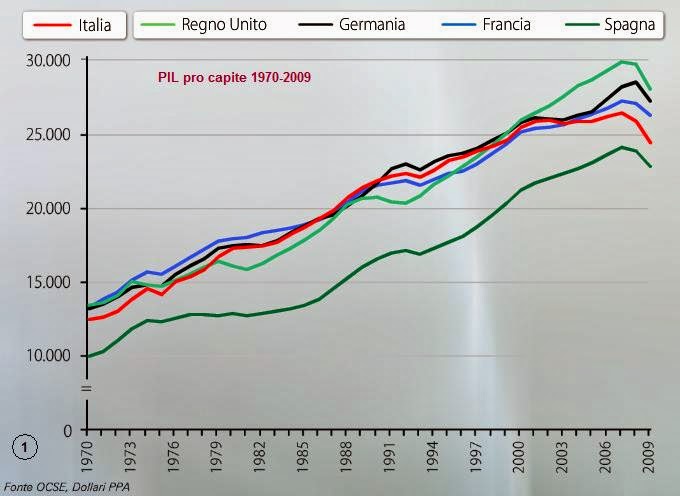Se scrivo qualche semplice articolo sul tema dell'euro e di una sua (im)possibile uscita è solo per discutere la questione a livello 'accademico', pour parler, come si fa di argomenti più o meno seri al bar con amici, perchè seriamente parlando quantomeno l'Italia non uscirà mai di propria iniziativa dalla moneta unica e questo per molti motivi. Vediamo i principali.
Supponiamo che alle prossime elezioni europee vi sia una netta affermazione di quei partiti che propongono un ritorno ad una moneta nazionale e che a seguito di questo esito e di eventuali crisi politiche l'attuale governo cada e si vada alle urne facendo vincere ancora chi desidera abbandonare l'euro.
Il Presidente della Repubblica incaricherà quindi una persona di formare il nuovo governo che, non appena insediato, proverà a mettere in atto la promessa elettorale, ma non prima di aver sentito i pareri delle varie rappresentanze del mondo economico e sociale, cioè le rappresentanze sindacali dei lavoratori, quelle imprenditoriali, l'ABI, tecnici dei ministeri, la Banca d'Italia etc...
A quel punto mi sarà difficile credere che queste possano trovarsi favorevoli con questa scelta visto che oggi lo dicono più o meno chiaramente che una eventuale uscita avrebbe delle conseguenze negative o quantomeno imprevedibili e dagli esiti incerti.
Confindustria sicuramente non potrà appoggiare una decisione simile per il fatto che molte grandi e medie aziende ad esempio emettono obbligazioni per raccogliere sul mercato finanziamenti per effettuare investimenti, obbligazioni in euro o altra valuta che devono essere rimborsate nella medesima valuta. Sarebbe quindi un danno non di poco conto se si adottasse una valuta soggetta a svalutarsi rispetto a quella di emissione dell'obbligazione, si dovrebbe pagare alla scadenza un capitale maggiorato.
Un altro aspetto che non piacerebbe alle imprese riguarda la situazione di incertezza a seguito di una simile decisione che bloccherebbe tutti gli investimenti, o quantomeno gran parte, perchè alle imprese servono prospettive sicure e un clima di fiducia per decidere di investire. Si andrebbe quindi incontro ad una situazione di attesa che di certo non farebbe ripartire l'economia come i fautori dell'uscita dall'euro professano.
Banche - Anche per gli istituti di credito e per lo stesso motivo delle imprese non sarebbero favorevoli a lasciare l'euro. Anche le banche infatti emettono obbligazioni e inoltre si prestano denaro a vicenda per la propria attività, denaro che deve essere restituito nella stessa valuta originale pertanto adottare una moneta destinata a svalutarsi implicherebbe un aggravio delle passività.
Banca d'Italia - Credo che anche la nostra banca centrale storcerà il naso di fronte ad una scelta populista come il ritorno alla lira o comunque ad una nostra valuta, specialmente quando nel suo bilancio registra linee di credito da altre banche centrali e dalla BCE per centinaia di miliardi di euro, che in caso di adozione di una nuova moneta saranno da restituire sempre in euro. Nel bilancio 2012 questa voce ammontava a poco meno di 254 miliardi di euro (16% del Pil):
Ministero del Tesoro - Non sono in grado di sapere quale opinione potranno dare i tecnici del ministero dal quale dipende la gestione del nostro debito pubblico e la relativa collocazione sul mercato dei titoli di Stato, ma la mia personale opinione è che non sarà favorevole in quanto faranno presente con ogni probabilità la prevedibile diffidenza da parte degli investitori ad acquistare titoli con un rendimento insufficente a coprire la prevista svalutazione della nostra nuova moneta rispetto a quella di emissione.
Se si decidesse di lasciare l'euro occorrerebbero mesi prima di poter essere in grado di emettere titoli nella nuova valuta (es.lire) e nel frattempo si sarebbe costretti a farlo sempre in euro. Ora, chi acquisterà mai un titolo qualsiasi che renda ad esempio il 3, 4 o anche 6% annuo con la prospettiva di vedersi rimborsare un 20 o 30% (o anche più) in meno a seguito della svalutazione della nuova moneta con cui verrà rimborsato il titolo rispetto a quella originale di emissione (euro)?
Esempio: il giorno dopo l'annuncio di uscita dall'euro il Tesoro colloca un BTP del valore nominale di 100 euro al prezzo minimo di aggiudicazione pari a 97 euro e una cedola del 4%. A prescindere dalla durata di questo BTP sicuramente il rendimento totale sarà inferiore ad una semplice svalutazione della lira anche solo del 20% (secondo le previsioni più ottimistiche) rispetto all'euro. Infatti dopo aver adottato una nuova moneta i titoli di Stato con ogni probabilità saranno tutti convertiti in questa, ergo chi compra paga in euro e si vede restituire lire (svalutate).
Per evitare così grosse quantità di invenduto al Tesoro non rimarrà che garantire gli investitori che i titoli emessi nel periodo transitorio verranno ripagati nella medesima valuta di emissione non esercitando quindi il diritto della lex monetae. Questo comporterà però un onere maggiore in quanto aumenterà l'importo capitale da restituire e quindi il debito pubblico.
Sindacati - Nonostante siano meno coinvolti direttamente i sindacati dei lavoratori, dopo aver ascoltato le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni delle imprese, non avrebbero motivo di appoggiare una scelta di uscita dall'euro, visto che da questa potrebbero derivare gravi conseguenze al mondo del lavoro.
Insomma una cosa è ascoltare sui social network i commenti di comuni cittadini spesso non competenti a sufficienza di questioni così complesse, compreso quella del sottoscritto, e fare propaganda elettorale per catturare qualche voto in più illudendo la gente, ma un'altra è invece quella autorevole delle categorie sopra citate assumendosi eventualmente la responsabilità di una scelta che potrebbe causare gravi conseguenze al Paese.
Non potrebbero certo difendersi dicendo "lo suggerivano alcuni premi Nobel (per l'economia)". Anche perchè non è così, almeno per l'Italia.